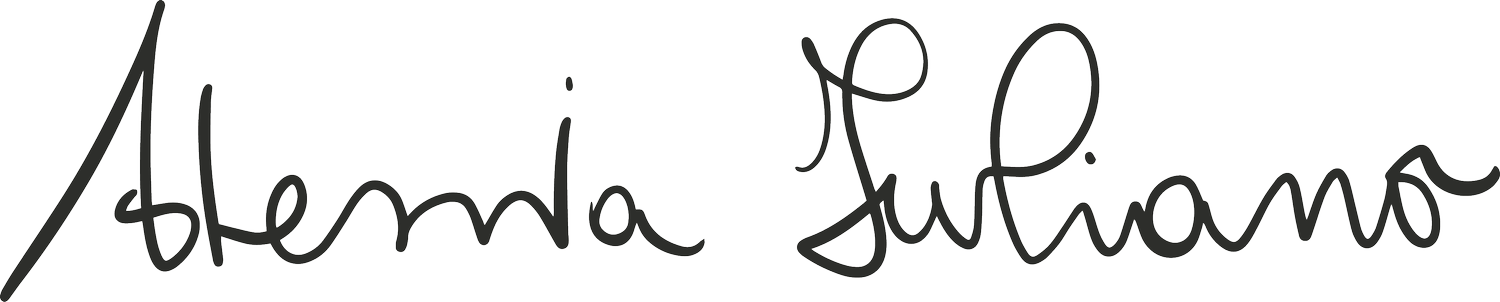Risalire l’alienazione: la profezia di Baudelaire tra i versi di Clery Celeste
Clery Celeste, Salvare il necessario, Pietre Vive Editore, 2023
di Alessia Iuliano
Cosa significa “necessario”? E cosa implica il passaggio di questo termine da aggettivo a sostantivo nel titolo e nella visione profetica della poetessa Clery Celeste?
Tommaso d’Aquino parlerebbe di “causa incausata”, “causa prima”, il Necessario da cui tutto deriva: Dio. Trovo interessante accostare la definizione tomista al titolo della seconda raccolta di Clery Celeste, Salvare il necessario (Pietre Vive Editore, 2023). Sebbene a una prima lettura abbia pensato che tra queste pagine non ci fosse la benché minima allusione al Necessario inteso come metafisico, divino, e che la poetessa stesse alludendo a un altro tipo di necessario – un’urgenza ineludibile e terrena – a distanza di quasi un anno dall’uscita del volume, mi sembra che in queste pagine ci sia anche qualcosa di ulteriore: un’ombra misteriosa, forse spirituale, pervade il testo.
Ma andiamo per ordine, l’opera di Clery Celeste si compone di cinque sezioni: quattro movimenti (Siamo costretti a chiuderci in casa, Luce nel mio sangue, Con tutta la pelle aperta, Questa cosa che mi abita dentro) e un controcanto (Di figlio in padre), per un totale, appunto, di cinque parti. Ciò che mi affascina molto di quest’opera, nella sua forma, è che la poesia di Clery si sviluppa immersa nella cruda e corporea realtà, entrando così in contrasto con tutto quel contesto teologico a cui ho accennato.
Viviamo vite separate
in questo strisciare d’auto,
ognuno dentro le sue costole,
metallo e plastica insieme.
Ci siamo fusi con le cose,
più nessun disperato respiro,
più nessun tentato rancore.
Vorrei concentrare l’attenzione dei lettori sugli ultimi tre versi del componimento: “Ci siamo fusi con le cose, / più nessun disperato respiro, / più nessun tentato rancore”; e ora permettetemi di farli dialogare con questi altri, in cui nientemeno che Baudelaire descrive il peggior vizio dell’uomo contemporaneo, la noia: “Se pur non fa alte grida, né grandi moine, / farebbe volentieri della nostra mente rovine / e in uno sbadiglio ingoierebbe il mondo”[1].
Ecco, a me sembra proprio che la poetessa ci stia raccontando le conseguenze di quelle rovine del cui pericolo Baudelaire ci metteva in guardia. Fin dalla prima sezione dell’opera, infatti, emerge chiaramente un senso di frattura fra l’individuo e il mondo che si rinviene anche nella frammentarietà del verso.
Abbiamo rinunciato alle foglie
marce dei fiori caduti in terra
per un'erba sintetica nel perimetro
sicuro e perfettissimo del niente,
del vento indotto, del verde
sradicato alla sua origine.
L’uomo ha perduto l’umano, ebbro di noia e privo di senno si è convinto “del niente, / del vento indotto, del verde / sradicato alla sua origine”. E si è fatto egli stesso creatore, per questo forse il Necessario da salvare è quello con la enne maiuscola. Il rischio è alto altrimenti: “Potete essere chiunque / tanto non sarò in grado di riconoscervi / il mostro del quale vi fidate è al sicuro”, scrive Clery. “Essere chiunque”, vale a dire essere nessuno, un numero, un individuo senza più un nome; è per questa ragione che mi pare ci sia nella poesia della Celeste tutto il grido di una condizione esistenziale in lotta per risalire dall’alienazione.
Senza pronunciare la parola
siamo abituati a sentimenti
del tutto bidimensionali.
Comprimiamoci pure ancora
nella vastità dello schermo.
Ecco il paradosso della modernità, cinque versi per dire la superficialità che rischiano le relazioni odierne, bidimensionali, compresse in uno smartphone.
La poetessa porge attenzione alla brutalità dell’esistenza, non al buono. Anche la luce, elemento che ritorna più volte nei testi, non offre consolazione, lo stesso io non è esente dalla disumanizzazione indolore.
Questa volta sono stata io
diventare disumana è stato semplice
radere al suolo ogni impianto collettivo,
nessun contatto visivo, nessun contatto
uditivo. Apriva la bocca come i pesci
il vecchio di fianco a me in treno
roteava gli occhi in una apnea indolore.
Sembra non vi sia alcuna via di salvezza, nessuna speranza nel panorama di desolazione tracciato dal verso della Celeste, e forse – come leggiamo in quarta di copertina – “soltanto superando l’illusione è possibile maturare una nuova consapevolezza della propria libertà […] per quanto dolorosa”. Che l’illusione citata abbia a che vedere con la falsa felicità? Quella legata al consumismo e al culto dei feticci? Se è così, allora ciò che ci deve interessare valorizzare è proprio quel dolore figlio dalla consapevolezza. Contro l’anestesia collettiva, l’antidoto che la poetessa sembra suggerire allo “strappo della vita” è l’amore diffuso, sebbene sofferto; come si evince leggendo questo testo, a mio avviso, tra i più belli dell’opera:
Arriverà e non sarà affatto come pensavi
l'amore ritorna sempre
composto o smembrato
sarà nel sorriso della cassiera
del ciclista che lascio passare
e se non sarà del mio cuore
va bene lo stesso, purché sia
mutata la misura sia comunque,
gli occhi aperti, come le braccia
e il resto del corpo.
Ecco la pienezza che non nasce da noi, ecco il mistero. Di seguito alcuni altri testi tratti dalle diverse sezioni:
Hai ragione quando dici che passo
il fuoco nelle mani, che rischio
di bruciare quel che trovo
ma cosa posso farci
se io prendo fuoco intera
se almeno nel dolore riesco a essere
una qualche forma di luce.
*
Nelle sere di disagio
ti sento che hai nel fiato
quell'odore di bestia
che bracca la volpe.
L'acchiappi da dietro, un volo secco
da cane che sa che
la stagione delle piogge
si allontana, che deve fare scorta
perché l'amore fa troppo male
ci rende deboli
portatori di semi.
*
Ho cercato le parole
ed erano tutte spezzate
sul diaframma. Il respiro cerca
e non smette
di respirare, fare a gara
in questa pancia
tutta vuota
a riempirla di cose
in cui non sei.
*
Non sarebbe cambiato niente
se anche fossi arrivato in tempo
per vedere l'ultimo spettacolare
strappo della vita. Mi dice proprio così
seduto in sala tac, adagiato con la schiena
un po’ molle.
— Note —
[1] Versi tratti da Rondoni Davide, L’allodola e il fuoco. Le cinquanta poesie che accendono la vita, La nave di Teseo, Milano 2017.
Nota comparsa per la prima volta su clanDestino