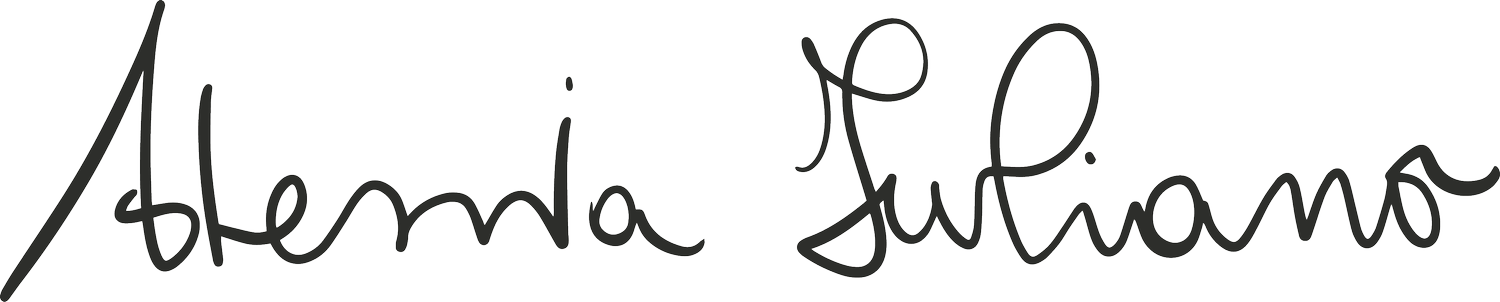Risonanze dal Selvatico, la meditazione di Gaia Boni
Gaia Boni, Figlia del selvatico, Minerva Edizioni, 2024
Quelli di Gaia Boni sono «versi di risonanza, eco di ciò che è successo nelle ore o nei giorni precedenti», come rivela, d’altra parte, l’autrice in una delle cinque domande a cui risponde nelle pagine immediatamente precedenti alle poesie di questo suo nuovo libro, La figlia del selvatico, edito dalle Edizioni Minerva nel 2024. Anche senza queste “cinque domande” — che, probabilmente, hanno più la funzione di dare voce all’autrice rispetto al proprio lavoro che di tracciare coordinate esplicite per la lettura dei testi —, i titoli delle tre sezioni del volume (La neve conserva in sé il mistero del tempo, Un’eco è rimasta di sola terra e radici, Ferðaljóð) suggeriscono già alcune posture con cui accostarsi all’opera. La prima, e forse la più evidente, è guardare alla natura, al Selvatico in ogni sua estensione, come si guarda un Essere. Un Essere che, come tale, non solo si relaziona con noi, ma agisce in noi e — suggerisce il titolo — noi ne facciamo parte, ne siamo i figli. La seconda postura riguarda il senso di continuo stupore che non dovrebbe abbandonare il nostro occhio, e ha a che fare col fatto che in islandese esista una parola precisa, Ferðaljóð appunto, per tradurre la locuzione “poesie di viaggio”, ciò mi scuote e non poco perché, in effetti, separare la poesia dal viaggio impoverirebbe entrambi. D’altra parte, in queste poesie si compie uno strano viaggio, la metamorfosi dell’umano che si dissolve nel paesaggio regalandoci immagini come: “Cielo di pelle calzata dal vento”, “[…] la mia schiena piegata/collina pallida di vertebre […]”. E la natura non è semplicemente sfondo, ma diventa essa stessa la lente, il filtro attraverso cui la sguardo della poetessa esplora il quotidiano, pur nell’intimità di un amore, come leggiamo in questa poesia:
Oltre il verde delle tende si spacca la voce del cielo
accolgo la pioggia a lenire il suono di questa aria insonne
- ti scrivo nell'attesa del tuo scrivermi centellinato
e nella sospensione quotidiana in cui mi lasci
ritrovo il peso dei corpi celesti e delle nubi
i silenzi degli a capo
la tua barba corta che contiene
tutto il mio inverno.
In quest’opera, la Boni sembra mettere in ordine le priorità di chi è al mondo con coscienza:
Vorrei un tempo per le cose banali
noi che viviamo solo di parole baciate
- unico alfabeto che so concepire -
cogliere svogliatamente gli steli dei lampioni accesi
sulla strada di una casa germogliata in sogno
e non viaggiare per raggrumare in ore strette lo spazio
ma distenderlo nella fortuna del sempre quotidiano.
Certo, non potrebbe essere diversamente, specie se riflettiamo sulla categoria sociale della “risonanza”, intesa come «prima di tutto la condizione o la modalità di un rapporto dinamico con il mondo, in cui il soggetto e il mondo […] entrano in contatto e si trasformano reciprocamente».[1] La fortuna è tutta qui, ci dice la poetessa: nell’esserci e nel prendere atto di questo spazio disteso del sempre quotidiano.
Vi è, dunque, in questi versi tanto evocativi quanto taglienti, una più o meno esplicita lode del Selvatico. L’io e il tu, interrelati col mondo naturale, cedono la scena alla natura e la stessa “esperienza” del Creato diventa voce che chiede attenzione. Come suggeriva fin da subito il titolo della prima sezione, la natura conserva un mistero che, nel silenzio del vento, ha molto da insegnare all’uomo. Leggiamo, infatti:
I larici affilati tacciono tutti insieme
in un silenzio che non è solitudine
ma assenza di vento
- dovrei imparare da loro a cullarmi
allungando allo spasmo i nodi e le tane
degli altri scavate dentro un abbandono di picchi
invece rinserro tutti gli anelli
tra due rotule di legno
e mi lascio colare lungo i limiti
resina che piange la mancanza
Nel momento in cui leggiamo “I larici affilati tacciono tutti insieme”, mentre la poetessa dice di lasciarsi colare “resina che piange la mancanza”, cogliamo indiscutibile la funzione di madre-maestra e mistero che Gaia Boni riconosce al Selvatico, in affinità con alcune voci della poesia (italiana e non) tra ‘800 e ‘900, penso a Pascoli e alla natura-madre benevola, ma anche agli stessi Whitman e Rilke, tra gli altri, ai quali la poetessa rivela di accostarsi. Ecco, con Gaia Boni, il silenzio dei larici, infatti, non è solitudine/vuoto ma assenza di vento/serenità, simbolo di una calma profonda da apprendere, condizione evidentemente ancora preclusa alla voce dell’io. E proprio in qualche componimento più avanti, troviamo la conferma in queste parole: “io nel disequilibrio della frana / e nessuna radice che possa nominare”. Non sia che per nominare le radici dovremmo smetterla di dire io sono intero, compiuto, autosufficiente? Forse il punto, come scrive sempre la poetessa, è un altro: “il nostro mondo è così giovane / da non conoscere la parola dell’alba”.
Provo ad accostarmi a quest’ultimo verso – e spero di non presumere erroneamente l’intenzione dell’autrice –, “la parola dell’alba”, in punta di piedi: forse si tratta proprio di un altro alfabeto, primordiale, che unisce l’uomo alla natura e al divino, un linguaggio ancestrale che sfugge alla modernità ma che, come l’alba – e per chi ha fede, come Dio –, possiamo ritrovare lì, a ogni nuovo mattino, pronto a rivelarsi a chi sa ascoltare.
Mi parli tacendo o mandandomi il vento.
Da quando i rami si sono mossi nel tuo nome la prima volta
puoi tracciare intorno ai miei fianchi esposti un anello in più
- da allora abbiamo affinato la lingua dei selvatici
fissando le parole tra muscoli in fremito
e sguardi che chiedono il tempo di passi o fughe.
Dietro le fronde dei miei occhi chiusi, cercami
tu che sai trovarmi nel mistero dei larici.
*
Il nostro mondo è così giovane
da non conoscere la parola dell'alba
ci muoviamo, labbra increspature di fiume
incerti quarzi bianchi
mastichiamo la sabbia - coperta di sonno -
contandone i granelli così le ore nostre
- mi cerchi la curva sciolta dei lobi che guardano i tuoi timidi
ragazzo tu, richiamo di foglie e luce ferita
abbiamo in bocca la pronuncia chiara del domani
ma ancora non ne conosci il canto.
*
Tenere vivi i fiori
mi ripeto a febbraio, in ogni fibra verde rimasta
rianimare stami pistilli corolle di lupina inesistenti
- non riesco a sradicare questa devozione al viola -
tu distante due lingue e un'esiziale possibilità di germoglio
io nel disequilibrio della frana
e nessuna radice che possa nominare
non un solo miraggio.
[1] H. Rosa, "Risonanza come concetto chiave della teoria sociale", Studi di estetica, XLVIII, 2, 2020
Nota comparsa per la prima volta su clanDestino