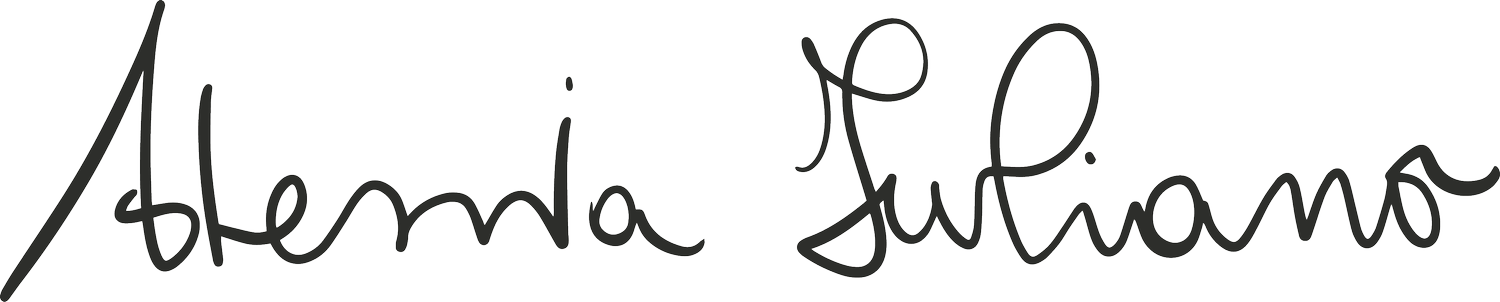Si può parlare di educazione senza poesia?
“Intervento nell’ambito del convegno “Dialoghi al femminile, parole in circolo. Le donne contano”, presso Il salone del Pubblico della Banca d’Italia, Cb. .”
Mario Luzi scriveva: “Niente ci riesce più confortevole che vedere un destino che si attua e che a poco a poco si adempie” [1]. L’essere umano cerca un senso, vuole riconoscersi in un cammino. Eppure, aggiungeva, “quante false immagini di sé un uomo si porta dietro, quanti ruoli indossa che non gli appartengono!”[2]
Nel 1945 Luzi metteva in guardia contro la perdita del proprio “segreto naturale”, un avvertimento che oggi è realtà. L’identità si appiattisce nei filtri di bellezza dei social, nella moda usa e getta, nel consumo veloce di opinioni e parole [3]. Anche l’educazione spesso si riduce a un accumulo di nozioni, senza contatto con la vita vera [4]. Ma se siamo qui, è perché crediamo che si possa invertire la rotta.
Come?
Non voglio ridurre tutto alla poesia, ma la poesia è al centro di questa sfida. Non è mai solo un esercizio estetico. È veggenza. Come diceva Rimbaud, permette di vedere oltre la superficie, di dare forma al caos. In un tempo che semplifica tutto in slogan e reazioni istantanee, la poesia è resistenza. È un atto di presenza.
Anche la mia opera – piccola, certo – si muove in questa direzione. E in questo percorso tra poesia, arte, musica e anche, più specificatamente, filosofia dell’educazione, una parola guida il mio lavoro: tenerezza.
Non intesa come sentimentalismo, ma come una forza educativa e trasformativa. La tenerezza è un archetipo del codice femminile, quasi materno. È uno sguardo stabile, che sa attendere, che sa restare. In termini pedagogici, la tenerezza è stanzialità: non significa immobilità, ma essere bene piantati, capaci di attraversare i mutamenti senza perdersi [5]. È la resistenza non violenta di chi conosce la propria natura e vi rimane fedele.
E allora, come si può parlare di educazione senza poesia? Senza la parola che apre ferite per curarle, senza il fuoco che trasforma l’esperienza in senso? Non si può.
Ne ho avuto prova nei laboratori con gli adolescenti. Ho visto la poesia diventare un gesto vivo, capace di risuonare nei ragazzi, di orientare. Una postura di risonanza, con sé e con il mondo.
Ogni parola vera lascia un segno. Una sola parola può far crollare il vuoto, rimettere in moto la sete di senso.
La mia ricerca nasce proprio dalla necessità di dare l’opportunità alle nuove generazione di dimostrarci che loro possono essere in grado di diventare liberi, autonomi e responsabili; possono essere stanziali in un tempo di mutamenti, se noi diamo loro gli strumenti necessari affinché siano capaci di avvicinarsi il più possibile a ciò a cui per loro natura tendono...
Per questo la poesia non è in pericolo, non è a rischio ma non può restare chiusa nei libri. Non può restare qualcosa su cui continuare a fare solo un certo tipo di elucubrazione mentale. Deve poter tornare gesto, postura. Deve tornare a essere una ferita aperta nel cuore delle cose.
Abbiamo un compito. Tutti. Non solo chi scrive o chi insegna. Dobbiamo restituire ai ragazzi, che sono il futuro, parole piene, parole che consentano loro di accedere al loro “segreto naturale”, quello di cui parlava Luzi. Non possiamo lasciarli orfani di senso.
Perché il risultato sapete quale è?, quello in cui il 73% degli adolescenti ricorre a filler e trattamenti estetici, influenzati dalle mode e dagli “universali” così li definiscono gli esperti, trasmessi e condivisi dai social, dagli influencer. Per fare un esempio…[6].
Per avviarmi verso la conclusione, vorrei aggiungere, rispetto alla condizione della poesia, ma anche dell’editoria, rispetto al lavoro che noi facciamo, questa riflessione compituta da Marina Cvetaeva diceva:
“L’arte è santa […] l’arte è la natura stessa. Non cercate nell’arte altre leggi che non siano le sue. […] forse l’arte è solo una ramificazione della natura. […] Ma è certo: un’opera d’arte è anche un’opera di natura: altrettanto nata e noncreata. […] Qual è dunque la differenza tra l’opera d’arte e l’opera di natura - tra un poema e un albero? Nessuna. Eppure, per chissà quali strade - di fatica, di miracolo - esiste. […] Vuol dire che l’artista è la terra che partorisce e che partorisce tutto.” Poi, aggiungeva, “È santa la natura? No. È peccaminosa? No. Ma se l’opera d’arte è anche opera di natura, perchè a un poema chiediamo conto e a un albero no - al massimo ci fa pena - se cresce storto? Perché la terra, procreando, non è responsabile, mentre l’uomo, creando, lo è. Perché la terra su cui cresce la vegetazione ha un’unica volontà: la crescita, mentre l’uomo deve volere che cresca il bene che egli conosce. […] Così l’opera d’arte è opera della natura stessa, ma un’opera che deve essere illuminata dalla luce della ragione e della coscienza. Solo allora essa serve il bene, come lo serve il torrente che fa girare la ruota del mulino […]” [7].
Emerge questo, che l’uomo è responsabile della sua creazione: la parola può essere un bene o un danno. Ecco il vero punto, secondo me, che deve essere al cuore di questo nostro dialogo: che cosa stiamo facendo con l’editoria, con la parola, con la poesia? Stiamo facendo del bene? Stiamo facendo rumore o rivelazione?
Questo è il motivo per il quale, se vogliamo, su invito di Enrica Cefaratti, ho scelto come parola da portare qui con me proprio “veggenza”. Perché in un mondo come questo, in cui spesso si dice, da anni si dice, che la poesia non vende, che ha un pubblico limitato o non ce l’ha; in un tempo in cui, appunto, è più facile concedersi questi slogan, che parlare piuttosto della complessità di quanto ci accade; la poesia continua a trovare lettori, a creare comunità là dove la parola vera, piena, viene seminata. E trova terreno fertile soprattutto nelle nuove generazioni… ben più disposte degli adulti ad incontrare la poesia nel mondo, e ritrovare sé stessi o il mondo nella poesia… io li ho incontrati questi ragazzi, che volevano più poesia, poesia - hanno detto loro - che illuminasse, che restituisse “tutte le emozioni umane”, così hanno detto a quattordici anni. Ecco perché la realtà ha bisogno di parole vere, piene. Ha bisogno di veggenti, non di ciechi ecco perché chi è acceso, chi vibra per quel “segreto naturale” non farà mai a meno della poesia.
— Note —
[1] M. Luzi, Del progresso spirituale, in L’inferno e il limbo (1964), il Saggiatore, Milano, p. 11.
[2] Ivi, pp. 13-14.
[3] Cfr. M. Tucci, Futuro incerto in un mondo difficile, in «Laboratorio adolescenza magazine», Milano, Biomedia s.r.l., n 2, 2023, pp. 12 - 13.
[4] Cfr. F. Julien, La vera vita, Bari- Roma, Editori Laterza, 2021, p. 3.
[5] Cfr. M. Stramaglia, Dentro la famiglia, pedagogia delle relazioni educative familiari, Roma. Amrando Editore, 2009, pp. 73-75.
[6] Cfr. Filler e trattamenti estetici per il 73% degli adolescenti italiani. Gli esperti: “Attenzione, rischi molto alti”, in «In Salute News», 6 maggio 2022, online.
[7] M. Cvetaeva, Il poeta e il tempo, Milano, Adelphi, 2022, pp. 73-75.